Per gran parte della storia moderna, il lavoro ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali dell’identità personale e sociale. In molte culture occidentali, la professione non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma una lente attraverso cui le persone definiscono se stesse e vengono definite dagli altri. L’espressione “sono un medico”, “faccio l’insegnante”, “lavoro nel marketing” non indica soltanto un’attività, ma un’appartenenza, uno status, un ruolo riconosciuto. Tuttavia, con l’evoluzione sempre più rapida delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, questo legame tra lavoro e identità si trova oggi sotto pressione.
L’automazione e l’IA stanno progressivamente sostituendo mansioni che fino a poco tempo fa venivano considerate esclusivamente umane: scrivere testi, analizzare dati complessi, elaborare strategie, insegnare, progettare, persino prendere decisioni. Non si tratta più di un futuro ipotetico, ma di un presente che avanza giorno dopo giorno. In tale scenario, la possibilità che interi segmenti occupazionali vengano ridisegnati o eliminati solleva interrogativi non solo economici o politici, ma profondamente esistenziali. Cosa accade quando il lavoro, che per secoli ha costituito un riferimento identitario stabile, non è più necessario? Quali forme di riconoscimento sociale ed espressione individuale rimangono, quando il contributo umano viene ritenuto secondario rispetto all’efficienza della macchina?
Una società fondata sulla produttività rischia, in tale transizione, di generare un vuoto. Non solo una disoccupazione materiale, ma una disoccupazione simbolica: l’impossibilità di riconoscersi in un ruolo, in una funzione, in un posto definito. Questo vuoto, per molti, potrebbe tradursi in una crisi di senso. Se non si è più ciò che si fa, allora chi si è?
Al tempo stesso, questa trasformazione potrebbe aprire la strada a nuove forme di consapevolezza. La fine del lavoro come elemento centrale dell’identità potrebbe costringere a ripensare la natura stessa dell’essere umano, spostando l’attenzione da ciò che produce a ciò che è. Potrebbero emergere, o riemergere, valori oggi marginalizzati: il tempo libero non come ozio, ma come spazio creativo e riflessivo; la relazione come fine, non come mezzo; la conoscenza come curiosità, non come competenza da monetizzare. L’identità, liberata dalla necessità di essere funzionale, potrebbe ricostruirsi su basi più autentiche, meno legate alla prestazione e più vicine all’esperienza, alla cura, alla presenza.
L’intelligenza artificiale è destinata a ridefinire molti aspetti della società, ma difficilmente potrà colmare il bisogno umano di significato. Non avendo coscienza, non può dare senso. La questione, quindi, non è soltanto occupazionale, ma culturale e filosofica. In un mondo in cui l’IA prende il posto delle persone in molti ambiti lavorativi, il vero nodo sarà comprendere se si sarà capaci di costruire un’identità che non dipenda esclusivamente da ciò che si produce, ma che sappia fondarsi su ciò che si vive, si sente, si immagina.






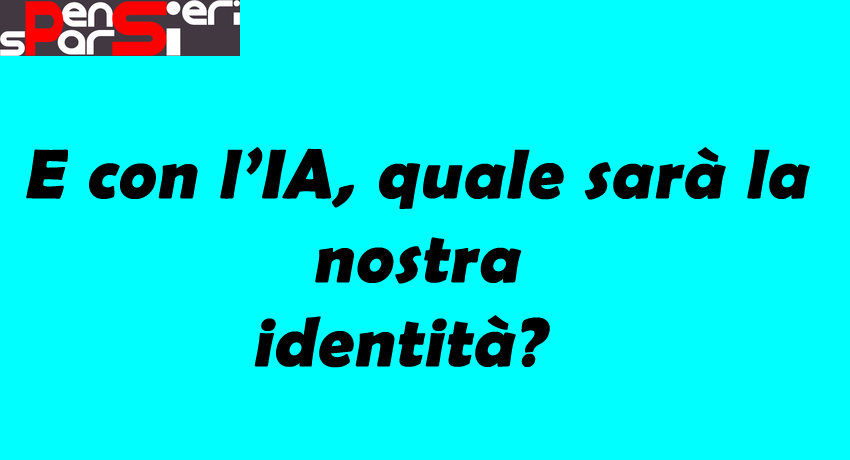
Riflessione assai interessante, cui mi permetto di rispondere con una citazione di Gaetano Salvemini: “La cultura è la somma di tutte quelle cognizioni che non rispondono a nessuno scopo pratico, ma che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani e non delle macchine specializzate. La cultura è il superfluo indispensabile “.
Con l’AI l’uomo non correrà il rischio di diventare una macchina ma appunto di svuotarsi di significato.
Quindi (ed è un augurio per il nostro partito) sarà fondamentale prendersi cura del percorso formativo dei ragazzi proprio perché riconoscano il valore del “superfluo indispensabile”, che aiuterà loro a riempire l’esistenza in modo ricco da un punto di vista emotivo e razionale.