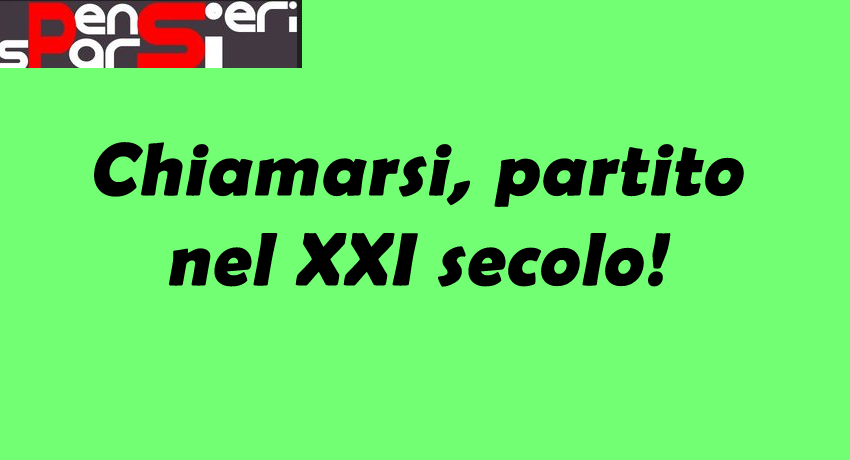C’è una parola che da tempo sembra aver perso cittadinanza nel lessico politico italiano. Una parola che, pur essendo centrale nella storia democratica del nostro Paese, oggi viene evitata come se fosse qualcosa di scomodo, fuori moda, addirittura sospetto.
Quella parola è: partito.
A parte il Partito Democratico, oggi praticamente nessuna forza politica italiana ha il coraggio – o forse la volontà – di definirsi con questo termine. Si preferisce parlare di “movimenti”, “liste”, “alleanze”, “civiche”, “comitati”, “collettivi”, “fronte”, “gruppi”, “famiglie politiche”, “reti”, “associazioni”.
Tutto tranne ciò che davvero servirebbe a ridare forza e dignità alla partecipazione politica: un partito.
Il termine partito è stato progressivamente demonizzato, come se racchiudesse in sé tutto ciò che la politica ha avuto di negativo nel corso della storia repubblicana. Come se essere parte di un partito significasse automaticamente clientelismo, rigidità ideologica, fedeltà cieca e logiche di potere.
Come se quella parola appartenesse a un tempo finito, remoto, da archiviare con vergogna.
Eppure, il partito – quello vero – è tutt’altro. È un luogo di elaborazione, di confronto, di democrazia interna. È una casa politica, una scuola di cittadinanza. È dove si forma una classe dirigente, dove si costruisce visione, dove si dà spazio alla progettualità, e anche al dissenso.
Il partito non è una parolaccia. È, anzi, una parola nobile.
Ma in un’Italia dove il disimpegno è stato mascherato da spontaneismo, e l’antipolitica si è travestita da autenticità, chi ha voluto ancora chiamarsi partito ha dovuto farlo controvento.
In controtendenza rispetto ai tempi del leaderismo fluido, della politica fatta nei talk show, dei programmi che cambiano a seconda dell’umore dei sondaggi, dei “contenitori” più attenti al branding che ai contenuti.
Ecco perché domani e domenica, a San Lazzaro di Savena, quando si aprirà il congresso nazionale del Partito Liberaldemocratico, quel nome non sarà soltanto una scelta formale. Sarà una dichiarazione di identità.
Un’affermazione forte e chiara: “sì, siamo un partito. E ne andiamo fieri”.
Essere un partito significa assumersi delle responsabilità. Significa lavorare insieme, discutere, decidere, e talvolta anche sbagliare, ma sempre alla luce del sole. Significa rifiutare la scorciatoia del populismo e la tentazione dell’ambiguità.
Significa credere che le idee abbiano bisogno di strutture, e che la democrazia abbia bisogno di organizzazione.
Siamo in pochi, oggi, a pensarlo. Ma forse proprio per questo è ancora più importante dirlo.
Anche perché, in fondo, che cos’è un partito, se non la forma più onesta con cui un gruppo di persone sceglie di fare politica insieme?
In un’epoca dove si nasconde il potere dietro i personalismi, i like e i video da trenta secondi, rivendicare il nome di partito è un atto di resistenza civile e culturale.
E se c’è chi pensa che la parola partito faccia male, puzzi di muffa o sia roba da archivi polverosi, è forse perché ha dimenticato il suo vero significato.
O peggio: perché ha tutto l’interesse a screditarlo, per mantenere un sistema di leadership verticali, dove la base conta solo ogni cinque anni.
Forse il termine “partito” non è di moda. Forse evoca qualcosa che qualcuno, con troppa superficialità, considera ormai “brutto, sporco e cattivo”*(citando questi 3 aggettivi non si può non ricordare il famoso film di Ettore Scola).
Ma a noi piace così. Perché dentro quel nome ci sono storie, radici, pensiero. E futuro.
* Brutti, sporchi e cattivi – Ettore Scola, 1976.